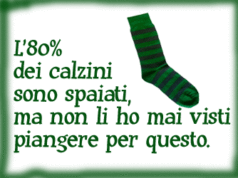Il Razzismo, un fenomeno ancora vivo
Il Razzismo, un fenomeno ancora vivo
Lo storico ebreo-polacco Albero Nirenstajin, con queste parole illustra lo sterminio degli Ebrei a causa del razzismo.
” Con questo modesto contributo intendo suggerirvi di riannodare l’esile filo della memoria. La questione che poniamo perciò è: un giorno, più o meno vicino, questo raptus sterminatore che attanagliò un’intera generazione mezzo secolo fa non potrebbe infiltrarsi nell’animo dello stesso popolo, o di un popolo diverso, per sfogarsi questa volta contro un simulacro sacrificale che richiami l’eccitante impresa della seconda guerra mondiale ?”
Posti di fronte a un simile quesito, la prima reazione sarebbe quella di rispondere che non è possibile il ripetersi di tale strage, proprio perché l’umanità ormai è stata “scolarizzata” contro tali pericoli dalla sua stessa esperienza storica, e non può tollerare che certe catastrofi possano ripetersi. Tuttavia, basta scorrere i giornali per vedere fatti di cronaca inquietanti, che negli ultimi anni sembrano essersi intensificati non solo in Italia, ma anche nel resto d’Europa. Questi eventi, apparentemente diversi tra loro, hanno in comune la stessa matrice: il razzismo. La profanazione di cimiteri ebraici, le scritte neonaziste sui muri delle metropoli, gli striscioni negli stadi che incitano alla violenza, gli episodi di quotidiana sopraffazione nei confronti degli extracomunitari: sono questi gli indizi di un atteggiamento di intolleranza che va diffondendosi nella nostra “civilissima” società.
Occorre definire con chiarezza la natura di quel fenomeno chiamato razzismo. Con il termine “razzismo” si intendono quelle teorie elaborate nel corso dell’ Ottocento e nella prima metà del Novecento, che stabilivano la superiorità biologica e intellettuale di una razza umana rispetto alle altre. La pretesa superiorità di una razza rispetto a un’altra aveva sempre il medesimo scopo : giustificare una conquista o un dominio imposto con la forza; si trattava di ” legittimare ” attraverso una concezione ideologica una situazione di sfruttamento e una posizione di potere. L’idea che fosse possibile dimostrare con l’evidenza della scienza esatta una simile tesi si diffuse soltanto nell’ Ottocento, soprattutto nella cultura tedesca, e si andò rafforzando nella prima metà del secolo successivo. “La razza – scrisse nel 1952 l’inglese Ashley Montagu, uno dei massimi studiosi del fenomeno- è la stregoneria del nostro tempo, il mito più pericoloso dell’uomo “. I tentativi compiuti per dimostrare l’esistenza di razze inferiori e superiori non ebbero mai alcun fondamento. Si pensi infatti, alla congettura dello studioso nazista Tirala, secondo cui ” le diverse razze umane hanno avuto origini indipendenti l’una dall’altra e si sono sviluppate da specie diverse di uomini-scimmia. Si tratta chiaramente di fenomeni assolutamente indimostrati e privi di credibilità. Vengono in mente, a tal proposito le parole di Adolf Hitler: ” Per mezzo di accorte bugie, incessantemente ripetute, è possibile far credere alla gente che il cielo è l’inferno, e l’inferno il ciel… Più grossa è la bugia, più prontamente sarà creduta “. L’atteggiamento tipico del razzista è quello di fare un’ affermazione perentoria la propria stessa affermazione come prova di verità.
Un sondaggio recentemente svolto fra gli studenti dell’ Università di Roma rivela che solo il 12 % degli intervistati ha un’ idea corretta del numero delle vittime del genocidio degli Ebrei, mentre il 52 % fissa il numero di tali vittime in poche migliaia di individui. Spetta dunque, alle istituzioni culturali, quali la scuola e la famiglia, tener sempre presente il ” filo della memoria “.
Probabilmente questa insofferenza, non nasce solo da una pretesa superiorità etnica, ma da uno stato di malessere generato da insicurezza e paura. La diffidenza nei confronti dell’ “altro”, ossia di chi è diverso sotto il punto di vista fisico, religioso, culturale e linguistico, è una reazione istintiva che non denota necessariamente il rifiuto dell’ integrazione, ma piuttosto una cautela che può essere superata.